Il mio folle viaggio nella musica elettronica
Questo articolo è nato come una specie di saggio. Dopo si è trasformato in una sorta di autodifesa. Nella sua forma finale vorrebbe essere il resoconto personale del mio folle viaggio alla scoperta della musica elettronica. Non è perfetto, non è esaustivo, e non è in alcun modo definitivo. Ma va bene così. Ne è venuto fuori un pezzo molto lungo. Mi dispiace.
Molto di quello che ho scritto si riferisce alla musica dance, ma soltanto perché essa è la componente più radicale e rivoluzionaria della musica elettronica. In realtà, quasi tutto quello che dico può essere applicato alla musica elettronica nel suo complesso. Buona lettura.
I: L’astrazione
Il primo disco di musica elettronica che ascoltai coscientemente è Selected Ambient Works 85-92 di Aphex Twin; un inizio niente male, considerando che è probabilmente il più bel disco elettronico della storia. Mi ricordo la sensazione che provai nell’ascoltare per la prima volta quelle tracce aliene, cosmiche, e al tempo stesso così magnetiche. Ma quello che mi colpì, più di tutto il resto, era il fatto che quelle tracce fossero solo musica, e non significassero niente. Richard James aveva creato quelle tracce senza la necessità di raccontare una storia, dare un messaggio o trasmettere un contenuto. Abituato alle mie ossessive ricerche su ogni parola che Thom Yorke avesse mai pronunciato – anche per sbaglio – era una prospettiva sconcertante. Certamente quelle tracce portano il segno di quello che Richard stava vivendo al momento nella sua vita personale o del grande periodo rave tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 che le aveva generate, ma, fondamentalmente, quella musica non vuole raccontare nulla. È solo musica. Non è certamente una regola assoluta nel mondo della musica elettronica: alcuni dischi hanno effettivamente una storia molto precisa da raccontare, come ad esempio Rival Dealer, l’EP del 2013 di Burial. Ma, salvo eccezioni, la musica elettronica si limita all’evocazione di un’atmosfera, un paesaggio sonoro, un valore di fondo. Non procede per messaggi, perché il contenuto della musica elettronica è sempre la forma, che si riflette nella comunità che l’ha generata.

Richard James aka Aphex Twin
Ci sono sicuramente vari motivi per cui questo sia accaduto. Uno è sicuramente il fatto che la musica elettronica nasce, come si intuisce dalla parola stessa, dalle macchine. Per forza di cose, il suono non poteva trasmettere un massaggio in modo così efficace come le parole, se non con lo strumento del campionamento. Gli artisti elettronici non si sono mai preoccupati delle parole e, quando l’anno fatto, hanno usato lo strumento del loop, che le trasforma in un fonema senza più alcun significato a furia di ripetizione. Siamo abituati a pensare che l’unico modo per veicolare un messaggio sia utilizzare le parole e, quindi, trovandoci di fronte ad una musica che di parole non può averne, pensiamo che il messaggio non ci sia. Invece, a fare più attenzione, scopriamo che il messaggio può passare nei suoni, nelle atmosfere, nei campionamenti, nelle citazioni, e in generale in tutto ciò che è intorno alla musica vera e propria. Il motivo principale, però, dell’assenza di un messaggio specifico è un altro. La musica elettronica, dopo decenni di sperimentazione, diventa davvero di massa quando nasce la cultura dance. Nasce fin dall’inizio non come musica di contenuto, ma come musica performativa. La bellezza di una canzone dance è sempre in secondo piano, il punto fondamentale è far ballare le persone. Se ti fa muovere, ha funzionato, altrimenti è completamente inutile. Ecco perché all’interno della cultura dance i valori e i messaggi non sono veicolati dalle canzoni in sé, ma dalla cultura stessa. Ballare, go raving, per dirla all’inglese, è un atto rivoluzionario in sé. Costruire un momento di estasi collettiva e di evasione è già di per sé creare un messaggio, che non necessita di alcuna parola.
Gli artisti elettronici mettono a nudo un concetto rivoluzionario. Un messaggio a ben pensarci anche abbastanza ovvio, anche se nella mentalità comune rifiutato come la peste. Il potere della musica non passa mai attraverso il significato. La musica può emozionarci, cullarci, aiutarci, unirci e costruire senza nessun messaggio. Perché la musica è sempre un mezzo, e come mezzo assume un significato solo quando siamo noi ad attribuirglielo. Prima di diventare musica di consumo e divertimento superficiale (sempre che esista un divertimento superficiale e uno profondo), la musica house nasce come musica autenticamente di liberazione ed emancipazione, perché prende vita nelle comunità nere e gay americane. La musica è sempre la stessa, salvo i suoi cambiamenti stilistici subiti negli anni, ma tra il ballarla ora in una discoteca di Ibiza nei tre giorni che il nostro volo low-cost ci mette a disposizione, oppure in un club gay di Chicago nel 1988, il suo valore ha tutta un’altra profondità.
II: A brave new world
La musica elettronica è sempre musica di rivolta e cambiamento. Di lotta attraverso il suono. E quando non lo è, ha tradito le sue origini, che la fissano come la musica degli altri, i rifiutati dalla società tradizionale, che decidono di costruire un mondo parallelo e inclusivo.
Potremmo parlare, come esempio su tutti, della nascita della musica techno. Alle origini della techno c’è la città di Detroit, un tempo una delle città più ricche ed in espansione degli Stati Uniti, ma all’inizio degli anni 80 una città in un lento, ma inesorabile, declino. Il sito 12’’ edit descrive molto bene il contesto in cui nacque la musica techno:
Dopo aver raggiunto il culmine dello sviluppo negli anni 50, la città cominciò a crollare sotto la forza della sua stessa grandezza. […] A Detroit c’è la simbolica autostrada M-102 (detta anche 8 Mile Road), una massiccia linea di separazione tra povertà e ricchezza, tra la città e le sue periferie. Tredici chilometri di zone alienanti che appartengono agli abitanti neri sono circondate dalle periferie dei bianchi su tre lati.
È in questo contesto che nasce l’opera dei Belleville Three: Juan Atkins, Derrick May e Kevin Saunderson, coloro che daranno vita al suono che anticiperà la techno classica che tutti conosciamo. La techno è probabilmente il genere della musica elettronica ideologicamente più definito, con una sua filosofia estetica e una sua riflessione sul futuro molto precise. Ma, tralasciando questi aspetti, è un genere che nasce soprattutto dal suo contesto sociale. Dall’alienazione, dalla decadenza di una città che sembra cadere pezzo dopo pezzo, dal razzismo e dal classismo dilaganti. Tutta la musica elettronica nasce fondamentalmente dagli esclusi, da coloro che la società rifiuta. Ecco che la musica diventa il pretesto per costruire un nuovo mondo, il nostro mondo. Dove la società brucia e aliena, gli artisti creano spazi di crescita e costruzione.

Gary Chandler al Packard Plant (foto di Brian Gillespie)
Questi valori, tipici delle prime scene house e techno (ma, andando ancora più indietro, anche della prima disco. Prima che diventasse la parodia di se stessa che tutti conosciamo, almeno), vengono portati ad un nuovo livello dalla scena rave tra la fine degli anni 80 e l’inizio dei 90, diventando una vera e propria ideologia della cultura dance. Il rave nasce come uno spazio di libertà ed inclusione totali, un mondo nuovo che fissa come unica regola quella del rispetto e dell’amicizia. Le scene underground elettroniche sono sempre stati dei luoghi di inclusione e di rispetto, dove si va per stare bene, per incontrare persone nuove, per lasciarsi andare totalmente. Sono state laboratori dove immaginare una società davvero nuova, una società dove non conta più nulla il colore della pelle o la sessualità. La produttrice Georgia, in un’intervista per Rumore, fissa molto bene questo concetto:
Il suono da club non è solo una scena musicale, ma rappresenta un movimento culturale. La musica dance ha sempre trasmesso un messaggio di libertà e diversità: ricordo un’intervista a Marshall Jefferson che raccontava la scena house di Chicago agli albori, prima di allora non aveva mai visto bianchi, neri, ispanici, gay, etero ballare tutti insieme. ( Rumore Num.337)
Spesso consideriamo la musica elettronica in modo superficiale, come uno dei tanti svaghi possibili del sabato sera. Ed è anche questo, certo, ma come ogni musica è anche e soprattutto cultura, una visione del mondo e della società. Il tentativo di cambiarlo, il mondo, un beat alla volta. E’, prima di ogni cosa, la musica degli esclusi e di chi non ha una voce. Ripercorrendo la storia della musica elettronica, sopravvalutare l’importanza della comunità nera, gay e queer è praticamente impossibile. Se la cultura mainstream se lo dimentica spesso, l’underground non lo fa quasi mai. Un esempio straordinario è venuto da NTS Radio, che nel Giugno del 2020 ha deciso di partecipare alla protesta di Black Lives Matter, non pubblicando sui social l’innocua immagine nera con abbinato hashtag, ma interrompendo le trasmissioni per un’intera giornata.
III: Estasi ed evasione
Una volta, in una discussione su Reddit, un utente mi descrisse la sua esperienza al Berghain di Berlino con queste parole: Trascendentale. Era come entrare in un universo parallelo dove tutti semplicemente vivevano per ballare come se nessuno stesse guardando. (Grazie Bruno92). Credo che questa frase colga perfettamente l’idea alla base di un’esperienza rave. Entrando in un club, tutto è pensato per sopraffare i nostri sensi: le luci stroboscopiche, il fumo che non permette di guardare ad un palmo dal muso, il calore, la musica così forte da essere fisicamente percepibile.
Dopotutto, la musica elettronica non ha inventato nulla, semmai ha aggiornato conoscenze ancestrali grazie alla tecnologia. L’uomo ha sempre cercato, nel corso del tempo, di raggiungere stati mentali alternativi. In particolare, la musica elettronica si basa su un’intuizione antichissima, quella secondo cui il ritmo incessante unito al movimento del corpo possano indurre nuovi stati mentali.
Un’intuizione che possiamo rintracciare nei popoli indigeni con le loro danze ipnotiche e percussive, come nei riti dionisiaci dell’antica Grecia. L’obbiettivo ideale, mille anni fa come oggi, rimane quello di raggiungere l’estasi. Etimologicamente, la parola estasi deriva dal greco ex, cioè fuori, e stasis, cioè stare. Possiamo tradurla quindi come stare fuori. Fuori da se stessi, ovviamente. È il momento in cui l’attività razionale del nostro cervello si spegne e possiamo sperimentare uno stato di annullamento del sé, di allontanamento dal nostro essere qui ed ora nella nostra corporeità. Inutile dirlo, è una delle esperienza più straordinarie e agognate dall’umanità. La cultura dance recupera questo concetto e lo porta avanti attraverso due direzioni diverse, ma complementari.
Da un lato c’è la ricerca musicale: nel tempo i produttori hanno cercato di enfatizzare l’aspetto più ritmico, quando non ipnotico, della musica elettronica. Il ritmo – ma anche altre parti della struttura sonora – diventano sempre più efficaci nel regalare un’esperienza sempre più trascinante, sempre più totalizzante. La musica diventa tutto, diventa l’unica cosa che esiste. L’idea del dj set è esattamente questa: fare in modo che la musica non si fermi mai, che il ritmo non dia un attimo di tregua, che la folla venga trascinata dal fiume in piena della musica. Una grandinata di stimoli e sensazioni senza fine, per indurre finalmente quel senso di distacco da se stessi e dalle cose che tanto si è ricercato nella storia.
Dall’altro lato, ovviamente, la ricerca di nuove sensazioni non può fare a meno della droga. Sarebbe inesatto pensare che senza di essa non possa esistere la musica, perché ci sono state scene e luoghi dove la droga non era un elemento fondamentale dell’equazione e personaggi che hanno rivendicato il loro non farne uso. È anche vero, però, che essa ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo della cultura rave. E, senza dubbio, la droga della musica elettronica per eccellenza è l’MDMA, meglio conosciuta come Ecstasy. L’MDMA ha due effetti fondamentali: da un lato quello di aumentare l’empatia, la sensazione di essere in comunità con gli altri, l’allegria e l’euforia; dall’altro quello di esaltare le sensazioni visive e uditive, trasformando l’esperienza della musica elettronica in un qualcosa di fisico. Attraverso l’Ecstasy, si è nella musica, si tocca la musica, ogni suono muove i nostri nervi e i muscoli del nostro corpo in maniera precisa e sbalorditiva.

La Love Parade a Berlino nel 1992 (foto dalla C/O Berlin Exhibition)
Tutti questi elementi, in definitiva, concorrono a creare un’esperienza di estasi ed evasione collettiva. Il dancefloor diventa propriamente un mondo parallelo, una realtà collettiva – come mi raccontava il tipo su Reddit – una sorta di regno delle meraviglie in cui rifugiarsi per qualche ora dalla realtà quotidiana. Un luogo provvisorio in cui la folla può diventare un unico organismo e ballare e respirare e muoversi allo stesso ritmo. Resident Advisor, facendo un confronto tra la cultura punk e quella dance, descrive il dancefloor come una zona temporaneamente autonoma con regole e comportamenti differenti dal mondo esterno. Queste regole sono molto semplici, eppure rivoluzionarie: la libertà più totale, il rispetto delle altre persone, il non giudicare gli altri, semplicemente, il lasciarsi andare senza nessun freno. L’esperienza prodotta dalla musica elettronica non è l’esperienza dell’io, è l’esperienza del noi. Per un periodo di tempo la coscienza individuale diventa collettiva e ci si può fondere totalmente con gli altri, come un unico essere che si muove e balla allo stesso ritmo.
Si potrebbero intavolare infinite discussioni, chiedendosi se tutta questa filosofia produca un reale cambiamento fuori dal club e se contribuisca a costruire un mondo più giusto e libero, o se rimanga un momento di edonismo fine a se stesso. L’idea di fondo, comunque, è di rompere per un momento le rigide regole della nostra società, e crearne di nuove e più umane. Regole che ci rendano davvero tutti liberi e tutti uguali. Nel finale della canzone Come Down to Us, Burial utilizza un campione di un discorso della regista Lana Wachoswski. La regista stava parlando della sua esperienza come donna trasgender, ma questa frase è curiosamente perfetta per descrivere l’idea di fondo alla base dell’esperienza rave: So, if this world that we imagine in this room might be used to gain access to other rooms, to other worlds, previously unimaginable.
IV: La figura dell’artista
Ricordo quando andai a vedere il mio primo dj set: Four Tet suonava al Locus Festival di Locorotondo. A mezzanotte in punto, preciso come un orologio, Kieran si mise davanti alla console e iniziò a mettere musica. Non disse una sola parola, e alle due in punto staccò e se ne andò. Ricordo che rimasi perplesso. Per me Four Tet era un idolo: ero lì per lui e mi aspettavo chissà quale show. Invece lui era salito su quel palco come un tizio qualunque, in maglietta bianca, e si era messo a mixare. Qualcosa non quadrava. Ma, con mia sorpresa, scoprii che a nessuno in quella folla fregava nulla, e probabilmente pochi tra di loro sapevano con precisione chi fosse Four Tet. Erano tutti lì per un solo motivo e per nessun altro: ballare.
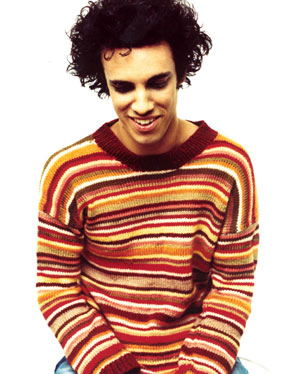
Kieran Hebden aka Four Tet
Questo aneddoto ci porta dritti al prossimo punto: la figura dell’artista nella musica elettronica. Una parte essenziale, quando non fondamentale, della musica pop è l’iconografia dell’artista. Ogni genere e ogni scena musicale ha impresso in noi una precisa estetica, che diventa simbolo di valori e di una visione condivisa. Penso ai capelli lunghi del rock classico, ai giubbotti di pelle del punk, alle croci e ai rimandi satanisti del metal, all’esibizionismo della cultura hip hop e alla sua retorica della strada. In molti casi si tratta di semplificazioni, ma, tutto sommato, queste descrizioni sono abbastanza fedeli alla realtà. Al contrario, l’artista elettronico sfugge quasi sempre a qualsiasi estetica precisa. Non solo, si sposta ai margini della scena. Fa del sua anonimità la sua bandiera. Il non dover usare qualcosa di così intrinseco alla persona come le parole e il canto per creare arte, o qualcosa di fisico e tangibile come uno strumento, gli permette di scivolare nell’ombra, nascondersi dietro le sue macchine. Gli artisti elettronici difficilmente salutano o interagiscono in modo diretto con il loro pubblico. Tendono a rilasciare meno interviste e a parlare il meno possibile della loro musica. Alcuni scelgono la strada di un anonimato totale e senza compromessi, come ad esempio Shinichi Atobe; altri cercano di allontanarsi il più possibile dal pubblico, dalle interviste, dalle foto, dalle logiche del mercato, come i Boards of Canada e Burial (di cui, fino alla pubblicazione del suo secondo disco, non si conoscevano né il volto, né tantomeno il nome).
Non si tratta solo della scelta da parte dell’artista di far parlare la musica per sé, o del fatto che a volte sia oggettivamente difficile descrivere una musica dove le parole non hanno alcun ruolo. C’è di più. È il tentativo dell’artista di arrendersi a quello che la musica elettronica è: un genere fluido, che fa dell’anonimato e del segreto la sua linfa vitale, che vive di assenza piuttosto che di presenza. All’interno della scena elettronica – e ancor di più di quella dance – il concetto di artista, disco, canzone tendono a sfumare e ad essere messi continuamente in discussione. Tutto scivola in un’energia collettiva e totalmente anonima, dove i nomi, i volti, i contenuti, i significati, non esistono più. Salvo poche eccezioni, dj che sono diventate vere e proprie star, come ad esempio Sven Vath nella prima scena techno tedesca, essi sono figure tutto sommato considerate importanti ai fini dell’esperienza, e lodate per le loro abilità e il loro talento, ma mai idolatrate. Non ci sono i fan urlanti in prima fila, insomma. Il discorso diventa ancora più evidente quando si parla di produttori che non lavorano come dj. Spesso tante pubblicazioni rimangono soltanto un vinile o un link per il download su Bandcamp, e poco altro. O, ancora, è molto comune che un produttore anche piuttosto conosciuto pubblichi lavori con alias differenti, nascondendosi dietro dischi di cui è difficile risalire al creatore, se non per ragioni stilistiche.
V: Remix e contaminazione
Di ogni scena elettronica esistono alcuni nomi sacri ed intoccabili, venerati come vere e proprie divinità. Vuoi per le loro innegabili capacità tecniche, per il loro essere stati i primi a creare un suono nuovo o per l’aver creato un immaginario che ha definito un nuovo genere. Ma, addentrandosi sempre più in una scena, si scopre che non è quasi mai questione di grandi nomi e di grandi dischi. Appena si fa un passo fuori dalle figure simbolo e si respira davvero l’aria calda e densa di un periodo o di una scena, si scopre la miriade di singoli, 12 pollici, remix, etichette e sotto-etichette, collettivi, artisti con decine di pseudonimi. In altre parole, nella musica elettronica non contano più quelli elementi simbolo a cui siamo abituati ad aggrapparci: l’artista come entità precisa e intoccabile, il disco come unità inviolabile, la canzone come oggetto assoluto e immodificabile. Simon Reynolds descrive molto bene questo concetto e la sua importanza nella scena elettronica, quando parla della sua esperienza nella scena rave inglese:
C’era una gioia liberatoria nell’arrendersi alla radicale anonimità della musica, nel non importarsene nulla dei nomi delle tracce o degli artisti. Il “significato” della musica apparteneva al macro-livello dell’intera cultura, e questa era molto di più della somma delle sue parti. (Traduzione mia da Energy Flash, mi scusi il signor Reynolds).
Il concetto di significato esposto da Reynolds è ciò che rende la musica elettronica totalmente rivoluzionaria. Un disco e una canzone in questo ambiente non valgono mai di per sé, come oggetti d’arte isolati, ma valgono in quanto arricchiscono un movimento o una scena. In quanto sono parte di un flusso ininterrotto e brulicante.
Nella musica elettronica è perciò fondamentale la contaminazione. Nella sua forma più esplicita, questo passa attraverso lo strumento del remix. Il remix dimostra come nulla nella scena elettronica (e non soltanto in quella dance) sia intoccabile ed eterno. Ogni canzone è costantemente presa, scomposta e rimontata, rimescolata. Nel processo di remix, la sensibilità personale può scegliere degli elementi di una traccia da evidenziare, altri da nascondere, altri ancora da aggiungere. Nella musica elettronica nulla esiste come oggetto da museo in un teca di vetro, ma tutto è disponibile alla continua reinvenzione e trasformazione. Nella scena rock, che procede invece per simboli, i fucili sono spianati verso chiunque osi mettere in discussione le figure mitologiche. Nessuno si sognerebbe di prendere Careful with that axe, Eugene e farci un remix, per dire (anche se si tratta probabilmente di un’esperienza mistica da tentare almeno una volta). Questa forma mentis è molto presente anche nella storia dell’arte: uno dei remix più famosi è probabilmente la Gioconda di Marcel Duchamp. Il suo remix era aperta provocazione. Nella scena elettronica è semplice routine.
Ma, a ben vedere, la contaminazione non si limita al remix, ma costituisce la nervatura più profonda di tutta la musica elettronica. Il fatto che il suono elettronico sia per sua natura prodotto da macchine, rende naturale l’idea di incorporare sorgenti e fonti diversi nella creazione di una canzone. Ogni traccia, infatti, non è mai il semplice prodotto del genio del singolo, ma un continuo rimescolamento di suoni, campionamenti, pattern, voci di altre tracce e altre fonti. Gli artisti attuano un continuo processo di ingestione di stimoli esterni e successiva digestione. Ogni fonte è adatta allo scopo: film, telefonate, altra musica, registrazioni, letture, poesie, suoni di ogni tipo. Tutti questi stimoli vengono stravolti, il loro significato muta e si adatta a quello di destinazione. In questo, gli artisti elettronici sono maestri del travestimento. L’esempio lampante è, ancora una volta, Burial. La musica di William Bevan vive nei campionamenti. Ogni esperienza viene incanalata nella sua musica, snaturata e trasformata in un nuovo significato, e servita nel momento esatto della canzone in cui qualsiasi suono, anche la frase più banale di tutte, brilla di luce propria. Aphex Twin, nella canzone 4, fa qualcosa di simile inserendo un frammento di una qualsiasi telefonata con suo padre. Un semplice: “Richard” “Yeah?”. Quel frammento non significa nulla, eppure in quella specifica posizione significa tutto. Altri artisti si spingono anche oltre, creando collage di campionamenti, dove ogni suono ha già vissuto almeno un’altra vita. Penso agli Avalanches con il loro capolavoro Since I left you, oppure alla prima produzione di Four Tet, da Dialogue a Everything Ecstatic, ai Books, a Caribou, ad uno dei sample più emozionanti e potenti nella storia della musica dance: Halcyon On and On degli Orbital.
La musica elettronica, in definitiva, rende palese quella verità che tutti ci ostiniamo a negare. Ogni opera d’arte è la copia di una copia di una copia di una copia. Ogni canzone è una copia di una copia di una copia di una copia. Non esiste l’intuizione pura e isolata dal mondo, ma ogni capolavoro nasce dal contesto che l’ha generato.
In questo sta il reale salto in avanti della musica elettronica: un genere che si allontana da tutto il resto e costruisce dinamiche e rapporti totalmente nuovi. La canzone, il disco, l’opera, tipici di una visione classica della musica, che il rock e tutti gli altri generi pop hanno ripreso, non valgono più nulla. Tutto è fluido, può essere smontato, distrutto, ricostruito, influenzato, unito ad altro. L’opera smette di essere un qualcosa di intoccabile, l’artista di essere un genio sulla montagna, e tutto può essere fatto a pezzi e ricostruito. La musica elettronica ha fatto molto prima quello che ora fa la cultura di Internet. Pensate ai meme: un meme esiste in virtù del fatto che ognuno può rubarlo e modificarlo a suo piacimento; aggiungere un particolare, cambiarne il significato, aggiungere una sfumatura diversa. Anzi, più un meme è rubato, più ha funzionato. La cultura del campionamento, del remix, della contaminazione tipica della musica elettronica ha messo in pratica questo principio parecchi anni prima che nascesse su Internet. È, in questo senso, ancora un genere postmoderno: fluido, anonimo, collettivo, primo di un messaggio monolitico.
Cos’è la musica elettronica, alla fine, se non un gigantesco gioco di specchi? L’artista scende dal palcoscenico e si ritira dalla vista, la canzone e il disco smettono di avere una centralità indiscutibile, il remix rimescola continuamente qualsiasi creazione artistica. Il significato è del tutto rifiutato. Cosa rimane alla fine di questa enorme opera di autodistruzione? La musica, ovviamente.
Foto di copertina: Four Tet al Village Underground nel 2018. Foto di Jason Evans e luci di Squidsoup.
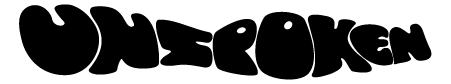




Scrivi un commento