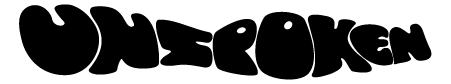Vite che sono la mia: un anno di Unspoken Blog
E possano questi dischi rompere le dighe
Arriverà un ciclone, forse ci lascerà stare
Che poi questa canzone non fa davvero così, la parola dischi l’ho aggiunta io. Credo che esprima bene l’idea di questo blog: un piccolo microcosmo protetto dove la musica può esondare, rompere ogni argine per riversarsi in ogni fessura. A volte pensiamo davvero che i dischi possano uscire da se stessi e andare a conquistare spazi delle nostre vite. Che possano calcificarsi nelle nostre ossa e diventare parte del nostro genoma. Forse a volte lo fanno davvero.
La musica ha sempre fatto parte della mia vita: è il più grande regalo che mio padre abbia potuto farmi. Negli anni, ho sviluppato un rapporto di dipendenza con la musica quasi malsano. Mi permette di rappresentare le mie emozioni, di renderle vere e vive e poterle affrontare. Quando quello che sento o che sto vivendo diventa suono, quando il suono si impasta con la materia della realtà, posso finalmente lasciar andare le cose.
Questo articolo sarà molto libero, un libero fluire dai miei pensieri alla tastiera del computer. Oggi Unspoken Blog compie un anno esatto, anche se il lavoro di costruzione del sito è iniziato parecchi mesi prima della sua apertura. Vorrei riflettere su cos’è stato questo blog nell’ultimo anno e cosa sta diventando e per questo sarà probabilmente un articolo parecchio palloso, oltre che molto personale. Chiudetelo pure, non me la prendo.
Unspoken è un blog che affonda le sue radici in vari progetti che ormai risalgono ad anni fa. Lo scheletro di questo blog – un luogo dove, fondamentalmente, parlo di dischi – è stata una pagina Instagram parecchio bruttina in cui descrivevo gli album che stavo ascoltando. Quelle recensioni sono poi confluite, ampiamente riviste, quando non riscritte da capo, nei primi articoli di Unspoken. C’è stata anche una trasmissione che facevo in una radio locale alle dieci di sera in cui parlavo di musica. Roba tremenda, come gli Autechre, i Boards of Canada, Oneohtrix Point Never o Four Tet. Registravo questa trasmissione di cui non fregava un cazzo a nessuno rigorosamente di notte, e poi ero praticamente l’unica persona ad ascoltarla quando andava in onda. Il nome del programma era preso dalla lingua parlata dai protagonisti della Collina dei Conigli di Richard Adams. Tutto sommato, è quello che è stato Unspoken Blog nell’ultimo anno: uno spazio in cui poter sfogare le mie ossessioni, praticamente certo di non essere letto da nessuno. La mia rigidità innata, il mio scegliere un mezzo così anacronistico come il blog, la mia incapacità di sfruttare i social per farmi conoscere, fanno sì che Unspoken Blog rimanga sconosciuto e introvabile. E in fondo mi va bene così, anche se non mi dispiacerebbe che qualcuno lo leggesse.
Il nome Unspoken, non è difficile capirlo, viene dall’album Rounds di Four Tet. Ed è davvero ironico che usi questa parola, tacito o sottointeso, come nome per un blog dove cerco di usare le parole per descrivere la musica che ascolto. Eppure, la parola unspoken riflette un concetto in cui credo ciecamente: le parole possono fino ad un certo punto, e alcune cose, semplicemente, non possono essere dette. Alcuni messaggi passano in altri modi che non sono il linguaggio, modi più sottili e fragili. Per me è stato sempre difficile dire alcune cose a voce alta, e la musica è stata quel linguaggio emergenziale che stavo cercando.

Le macine del Carrefour sono anche migliori di quelle di marca.
Una cosa ho sempre avuto chiara, fin da quando ho aperto il blog. Unspoken è un luogo in cui parlo di musica, senza avventurarmi in territori a me sconosciuti, con il rischio di dire soprattutto stronzate superficiali. Fermo restando, ovviamente, che a parlare di musica si finisce sempre a parlare anche di arte, di cultura, di queerness: in altre parole, di politica. Ed ogni volta che scrivo mi ricordo che anche di musica non ne so poi molto, o non ne so quanto vorrei. Ma non fa niente, sento il bisogno e l’urgenza di parlare dei dischi, per quelle che sono le mie conoscenze, provando sempre ad andare a fondo e non fermarmi mai alla superficie. O, almeno, questo è l’intento.
Che poi la storia del blog è più che altro una storia di articoli abortiti, piuttosto che di articoli pubblicati. Sarà stato per la mia pigrizia, sarà stato per la mia ossessione della perfezione (che in ogni caso non ho mai neanche lontanamente raggiunto). Ho lavorato per settimane o anche mesi ad idee per articoli e recensioni, ma alla fine quasi tutte sono state cestinate. Il fatto è che quelle poche cose che ho scritto mi hanno richiesto una fatica immensa nel tentativo di trovare le parole esatte, e il processo è durato settimane, una riscrittura dopo l’altra, una limatura sopra l’altra. Sono ancora orgoglioso di tutto quello che ho scritto in quest’anno, nonostante a rileggere ora gli articoli ne noti tutte le sbavature. Ma non fa nulla. Sto ancora lavorando sulla mia capacità di trasmettere le emozioni della musica attraverso le parole, di descrivere una canzone – specie se si tratta di musica elettronica. Non è facile. Citando i Wu Ming – che a loro volta citano Nada – l’amore è fortissimo, il corpo no. E tra le mille idee abortite aggiungo anche il tentativo di aprire il profilo Twitter di Unspoken: inutile dire che mi sono rotto i coglioni dopo appena una settimana. Non fa per me: l’amore è fortissimo, il corpo no. E Twitter è un posto che semplicemente non capisco.
Nel corso dell’anno, gli articoli che ho scritto sono diventati sempre più soggettivi. È un cambiamento che è avvenuto quasi da sé e che non ho fatto nulla per impedire: doveva succedere. Ho iniziato a scrivere sul blog cercando di essere oggettivo e impersonale, ma pian piano le recensioni sono diventate sempre più personali, sempre più lontane dall’obiettività. Ed in fondo mi va bene così: non ho le competenze e le conoscenze per poter davvero recensire musica, e piuttosto preferisco parlare di ciò che, banalmente, mi è piaciuto. A volte, poi, ho iniziato a scrivere articoli così intimi da decidere di non pubblicarli, perché, dopotutto, c’è un confine che non voglio superare. A questo proposito, mi ritorna in mente la scelta – anche questa nata quasi da sé – di rimanere anonimo nella mia identità, eppure mettere tutto me stesso in ogni parola che scrivo. Il mio volto – il mio nome – sono superflui. Non mi servono. Li lascio nella mia esistenza parallela e fisica. Aspettando di cambiare idea anche su questo aspetto.
Cos’era Unspoken? Un modo per tenere occupata la mente in un periodo di merda, forse. Una cosa che volevo rimanesse il più semplice ed essenziale possibile. Che ci fosse solo quello che davvero serve e nulla più: i dischi, gli articoli, i commenti, qualche foto. Unspoken continuerà ad esistere e crescere con pazienza.
Cosa voglio che continui ad essere Unspoken? Un semplice spazio in cui condividere cose belle. Musica bella. Perché ne vale la pena, ne vale ancora la pena. Perché gli artisti più strani e visionari e creativi meritano il nostro tempo e le nostre energie. Perché ci sono milioni e milioni di dischi meravigliosi e altrettanti ne verranno. Non è ancora finita.
(Foto di copertina di Sergey Vinograd su Unsplash)